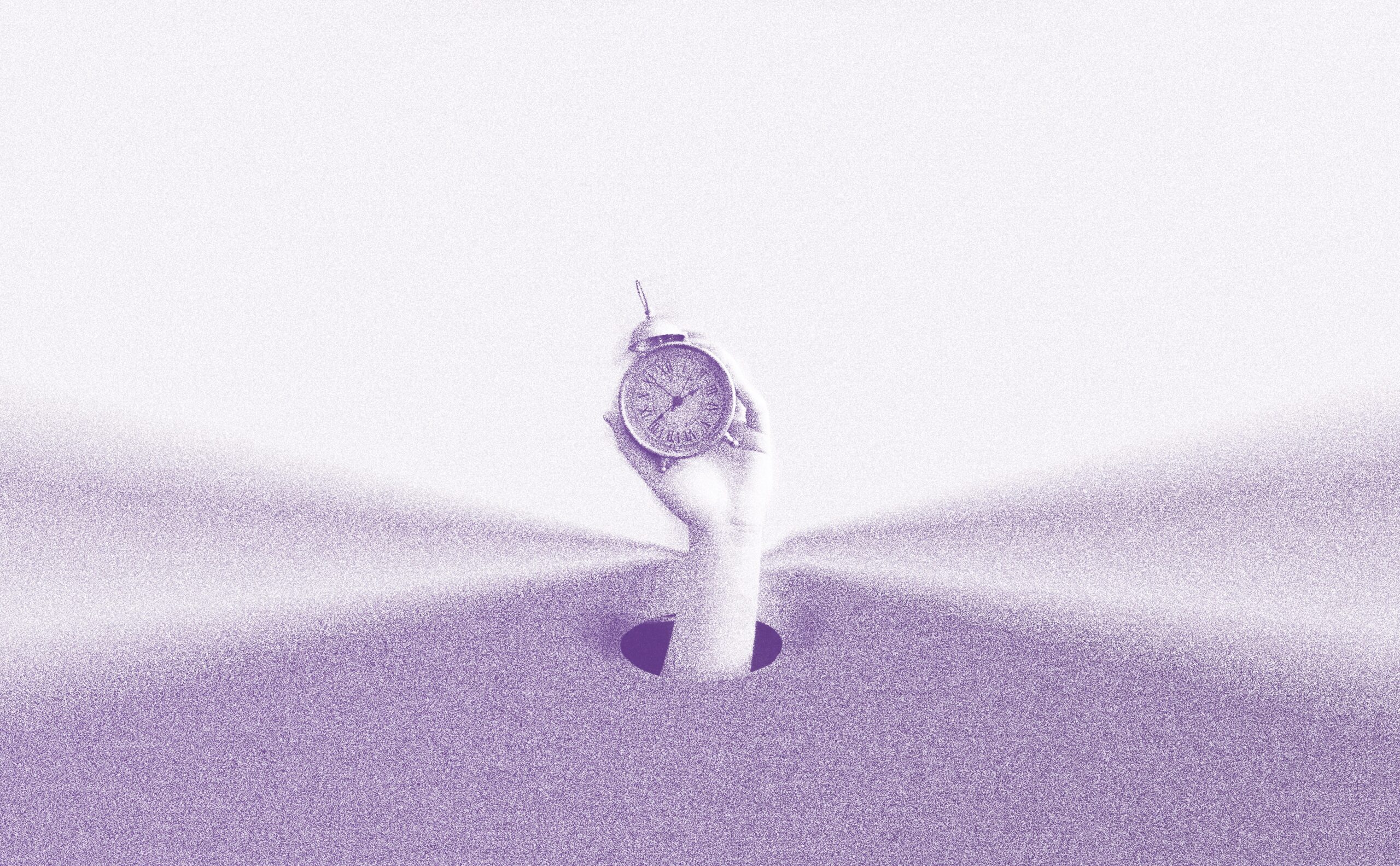Gli artigli del gatto e gli occhi di Democrito
“Professò, qua le cose sono cambiate”.
Era quello che pensava di voler dire, e quello che aveva taciuto per non dispiacere il vecchio insegnante. Dieci anni erano passati dall’ultima classe del liceo, ed in quei dieci anni si erano rivisti dieci volte. Dieci caffè, per modo di dire, perché poi non avevano mai preso un singolo caffè, ma cedrate, limonate, tè. Gli incontri erano un momento di sospensione, un resoconto annuale della vita di entrambi, il vecchio ed il giovane. Il giovane che lentamente perdeva la gioventù ed il vecchio che lentamente perdeva la vita, e ad ogni caffè lasciavano una testimonianza della loro esistenza, quasi un testamento memoriale all’adolescenza e al respiro. Tante cose erano cambiate veramente, e forse il professore lo aveva capito guardando ad ogni caffè gli occhi del ragazzo farsi cenere di una fiamma passata. Anche nei banchi di scuola le iridi lottavano con le eclissi, eppure gli sembrava di essere più capace di vincerle con la spinta dei diciotto anni, perché le possibilità si aprivano davanti. Ora era più stanco, affaticato. Amava ancora la vita, ma come si ama qualcuno di cattivo, l’amava con sofferenza perché lei lo faceva soffrire ogni giorno di più.
“Professò, non sono i sogni ad essere svaniti, ma il senso dei sogni”. Questo voleva dirgli, ed il prof gli avrebbe risposto con amarezza, perché con amarezza si risponde ad un figlio che viene sconfitto. E forse gli avrebbe chiesto chi fosse il colpevole della dissipazione, chi era stato tanto crudele da togliere il senso alle cose. “Chi è stato? Ieri un gatto, ma sempre Dio e gli uomini.”. Un gatto, avrebbe fatto ridere se non lo avesse pensato con serietà. La sera prima, dal piano terra dove abitava, aveva sentito nel giardinetto uno squittio. Dalle inferriate aveva visto l’erba muoversi ed un gatto guardingo vicino ad essa. Giocava con la zampa e sembrava dolce. Ma gli artigli squarciavano il topino che voleva solo trovare qualcosa da mangiare e soffriva e urlava il suo dolore in uno squittio terribile e ripetuto. Per dieci minuti aveva continuato a squittire e a muovere sempre più debolmente il filo d’erba, incapace di fuggire, sotto gli occhi guardinghi del gatto che non lo ammazzava. Lo lasciava lì, a soffrire. Forse il gatto avrebbe riso se avesse potuto, perché prima si annoiava ed ora si stava divertendo vedendo il topo scosso dalle sofferenze, mentre forse l’animaletto pregava un Dio dei topi che è come quello degli uomini: inesistente o sadico. Ma la cattiveria non è vizio degli animali, quella era semplicemente la natura. “Puttana professò, puttana”. Con il topo morto anche qualcosa era morto di nuovo in lui, perché le speranze sono per i ciechi e più lui invecchiava e più vedeva. “Professò, ci avete mentito. Democrito non si strappò gli occhi per pensare, ma per avere un poco di pace professò.”. Era stanco di saper le cose, anche se una spinta masochistica lo incollava sempre alle scoperte. Forse lo studente credeva ancora un poco nel suo titolo, o forse sperava che per una simmetria universale ciò che portava dolore, doveva prima o poi portare anche sollievo. “Storta va, dritta viene. Sempre storta non può andare. Lo dicevate voi professò, attribuendo ai detti popolari la stessa valenza dei precetti filosofici. Professò, qua la vita mi sembra sempre tutta curve. Trovo piccoli momenti di strada dritta, ma poi m’accorgo che era solo una curva più lunga. Si, lo so professò, il pendolo oscilla e i momenti di felicità sono brevi, ma non è questo il problema. Sto avendo una vita facile, e non mi arrogo il diritto della povertà e della sofferenza e ne lascio agli altri il dovere. Eppure, soffro professò. La mia esistenza è stata spuria dalla morte, tanto mia quanto dei miei cari. Eppure, muoio professò.”.
“L’hanno ammazzato troppo tardi. A chi? Socrate, professò. Ci ha inguaiati a tutti quanti. Eh, lo so, lo so che ero io che lo difendevo, che ne ero orgoglioso, ed ero sempre io che leggevo l’Apologia. Lo so professò, ma quello era un ragazzo ingenuo. Ora lo so, e non mi rammarico della cicuta, mi rammarico che sia arrivata troppo tardi. Dico io, o lo ammazzi subito o lo lasci vivere, tanto ormai il danno è fatto. Come a Gesù Cristo professò, a trentatré anni aveva già parlato assai. A quel punto era meglio lasciarli andare entrambi, che ormai gli occhi li avevano aperti e forse era meglio lasciarli fuori dall’orrore che vedevamo. Come? Si professò, lo faccio ancora. Si, ogni volta che passo a Roma porto comunque i fiori a Giordano Bruno. Le vecchie abitudini sono dure a morire professò, ma forse sarà pure che il rogo non lo merita nessuno. No, non è vero professò, è che Giordano ancora mi dà speranza con le sue stelle ed il suo universo infinito. Ma forse fra dieci anni ancora avrò cambiato idea e lo maledirò, lo esecrerò. No, non smetterò di portargli i fiori professò.”