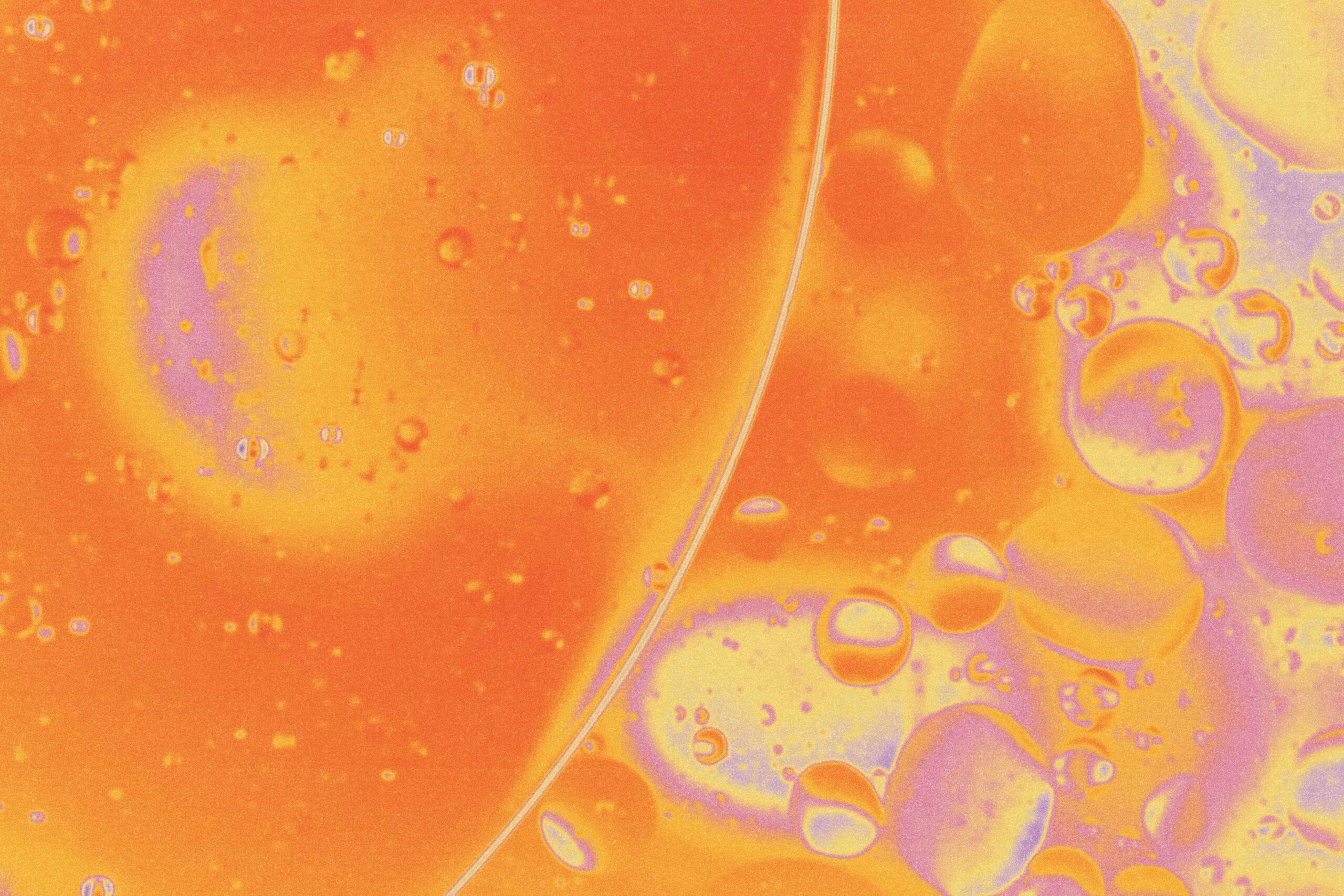L’odore
Quando alla terza spallata la pesante porta di legno ha ceduto, la piccola ha detto «Che puzza mamma!». E si è tappata il naso piccolo con le dita piccole, lo smalto rosa sbreccolato dall’ingordigia irrequieta dei denti richiamava quell’altro sfacelo, che era l’intonaco cadente, frustato via dai muri dalla violenza ignara del tempo, dall’incuria volontaria degli uomini.
Entrando, un olezzo stantio di muffa e cantina umida le ha avvolte. E per la prima volta Lina ha pensato all’individualità degli odori, come anch’essi, ugualmente alle persone, attraversino la storia, e negli anni conservino come scrigni i ricordi. Così, con quell’alito di grotta che approdava alle narici, e contro cui sua figlia si stagliava impersonando un fastidio, come a teatro una maschera rappresenta uno stato d’animo, a lei non arrivava un tanfo, un deliberato omicidio di profumi, s’imponeva invece la vita che non c’era più, quella dei suoi cari, della madre, della nonna, che lì avevano abitato. Venivano immagini, anche, non nitide, come se sopra vi fossero veli o ragnatele grandi e spesse come quelle che ora sostavano sul braccio di Lina, teso sullo stipite in attesa di entrare, la mente distratta attendendo il corpo non ancora pronto a valicare il confine, quello dell’uscio, e quello mai esaurito tra passato e presente. E un filo intersecava in quell’attimo, rapito all’eternità, i loro corpi fatti crune, per unirsi infine in un ricamo che attraversava le ore e i giorni e gli anni, e partiva dalle donne, sua madre, la madre di lei, la zia Cetta violentata dai fascisti che se ne stava sempre davanti al camino, a pigolare parole non parole come i pulcini dell’aia, poi lei stessa, infine sua figlia, ultima particella di DNA, equazione non voluta, poi amata. Gli uomini, invece, non c’erano mai stati, ché erano alla guerra, ché erano in taverna, ché se n’erano andati.
«Mamma, ma è tutto buio»
«Tranquilla, ora apriamo le finestre». Quelle, intanto, sentendosi nominare, povere vecchie, già s’erano stancate, e a toccarle sbuffavano perdendo pezzi di vernice che in frammenti venivano via aprendole, danzando dentro lame di luce, e le imposte, disturbate nel loro sonno, si lagnavano, gemevano, di malavoglia si schiudevano diroccandosi chi a destra chi a sinistra nella vedovanza dei vetri, al sole che fuori attendeva la vita.
E mentre la bambina se ne andava a curiosare per le stanze in chiaroscuro e Lina l’ammoniva «Attenta a dove metti i piedi. Guarda se ci sono chiodi», la casa ora negletta alla decomposizione del tempo, in sovraimpressione alla patina del reale s’animava del fuoco d’allora nel camino, del rumore del paiolo che strideva stritolando il gancio cui pendeva, nell’oscillìo perpetuo del suo essere, e spandeva ancora gli effluvi di polenta e somarino, disgiunti e insieme fusi a quelli della legna che avvampava, al fumo denso che a sbuffi s’involava nella cappa, contenendo avido i profumi condensati in una nube odorosa di resina e d’allori, di funghi e sottobosco, degli aliti, dei corpi, degli umori, dei sudori del lavoro, della festa. Perché ad attenderla, Lina, lì, nella casa, c’erano gli odori, anche se ora celati alla coltre del visibile ma vivi negli artigli del ricordo. «Gli odori» – le diceva la nonna – «sono memoria».
I vestiti erano ancora appesi, c’era la giacca nera della madre sull’attaccapanni e il grembiule marrone da giardinaggio della nonna. E sebbene, a un’ispezione del naso di Lina, l’odore loro fosse sepolto in superficie dall’intrusione pungente della polvere, persisteva nell’essere delle fibre.
Quanti odori.
«Non l’ho mai sopportato il suo odore. Sedici anni avevo. Ma che volete, s’era poveri, troppe bocche da sfamare. Era sempre una in meno se sposavi una figlia, che se la doveva sfamare qualcun altro. Quand’è morto, buon’anima, tutti via i suoi vestiti. Ne odiavo l’odore», raccontava la nonna. Forse detestava il sentore di lui, suo marito, perché era associato a sua volta alle botte, all’alito di vino dell’osteria, all’alba e alla terra dura da coltivare, ai geloni d’inverno, al sesso fatto come le bestie.
Lina ricordava gli odori della vendemmia, gli acini rossi, la sensazione dei piedi sopra i chicchi molli, liquefatti dalla canicola, quel su e giù delle ginocchia e la gonna che s’alzava, il sole e l’aroma di mosto, il sentore di zucchero, i piedi vermigli la sera, i cugini che ridevano, l’erba nei capelli che sapeva di sole, di bosco tagliato, di clorofilla, il pagliericcio condiviso di loro bambini, poi ragazzi. Singolarmente tutto era odore, quello della paglia, della pelle sudata sotto l’astro del mezzodì, dell’uva, della notte, con la sua emanazione di roghi e stoppie, coi suoi aliti di autunno che avvisavano l’arrivo dell’inverno, il bagno nel ruscello che sapeva di ferro, l’odore dell’epidermide bagnata che via via s’asciugava, la fragranza del melograno che nella lotta coi cugini, smembrandosi esploso, spandeva un’agre fragranza, e nel ricordo l’odore si mischiava ad altri odori, sì, ma anche alle urla di gioia, al movimento dei corpi che disarticolati scappavano tra gli alberi, alla sensazione delle foglie sotto cui i talloni scivolavano nel darsi alla fuga, alla macchia. Su ogni cosa si posava la sua specificità che era odore, che era immagine, suono, senso. In fondo era amore. E non c’era più niente. Nessuno v’era più a raccontare, sugli usci e sulle finestre, mentre le ciambelle dolci si raffreddavano e gli strofinacci asciugavano stesi sui davanzali di pietra sbeccati. Non c’era più la vecchina dell’angolo, col suo biroccino, a vendere la porchetta profumata di spezie, di pepe, rosmarino. Quando Lina passava di lì, al ritorno da scuola, l’odore era fame, era invidia nel guardare altre donne che non erano sua madre acquistare insaccati odorosi di finocchietto e anicetta. Nella sua casa prelibatezze significava festa, e quando quotidianamente la testa faceva capolino al ritorno da scuola colpiva una puzza di mensa, minestra di pomodoro, cipolle. La madre e la nonna chine sopra un ricamo, in penombra, in silenzio, spente da una tristezza che a lei sembrava ancestrale, ma che aveva avuto un inizio, non una fine.
La nonna, al paese, l’avevano sempre chiamata La vecchia, perché già dopo il primo figlio la pelle del viso le s’era increspata concentrica, come la superficie dell’acqua del canale quando il vento infuriava e i pescatori di anguille, tra cui il nonno, restavano lì a prendere freddo, ad accogliere lo sferzare dell’aria che sapeva di neve, ad accorciarsi la vita. Di figli ne aveva avuti otto, la nonna, La vecchia, ma non tutti erano arrivati all’età della ragione.
La nonna all’anagrafe si chiamava in realtà Adelaide, in memoria della città oltreoceano dove il padre di lei era andato a cercare fortuna, e da cui scriveva brevi lettere, tre, quattro, righe, Sto bene, così spero voi. Saluta i piccoli. Poi, le lettere erano finite. Anche l’assenza ha un odore, diceva La vecchia, era quello dei vestiti di suo padre rimasti per sempre senza un corpo e che la madre di lei annusava talvolta, nascosta agli stipiti, la minestra ignorata sulla fiamma del camino, dentro alla pentola, bruciava aderendo al fondo del tegame, che solitario, avvinto, si scontrava col fuoco.
Intanto, all’esterno, uomini e macchine attendevano di annientare lo sconquasso di mura, le cose, la casa. Fuori c’erano cose e case che prima non v’erano e facce che s’andavano affrettando alle loro cose, alle loro case, alle trame di altri personali odori che troppo presto sarebbero divenuti oblio o eredità. Era ora di andare, di lasciare, di lasciare andare, le cose, la casa, ma dentro la stanza erano in attesa, bloccate nel tempo, le vite, le immagini, l’amore, gli odori, i tini squarciati, gli utensili aggrottati di ruggine, i ricordi smarriti. Fuori le ruspe sbuffavano e stridevano con le loro braccia meccaniche. Dentro, la casa che andava abbattuta, che crollava, che nessuno voleva non volendo le vite, perché l’odore non vale moneta, e come il ricordo non vale niente.