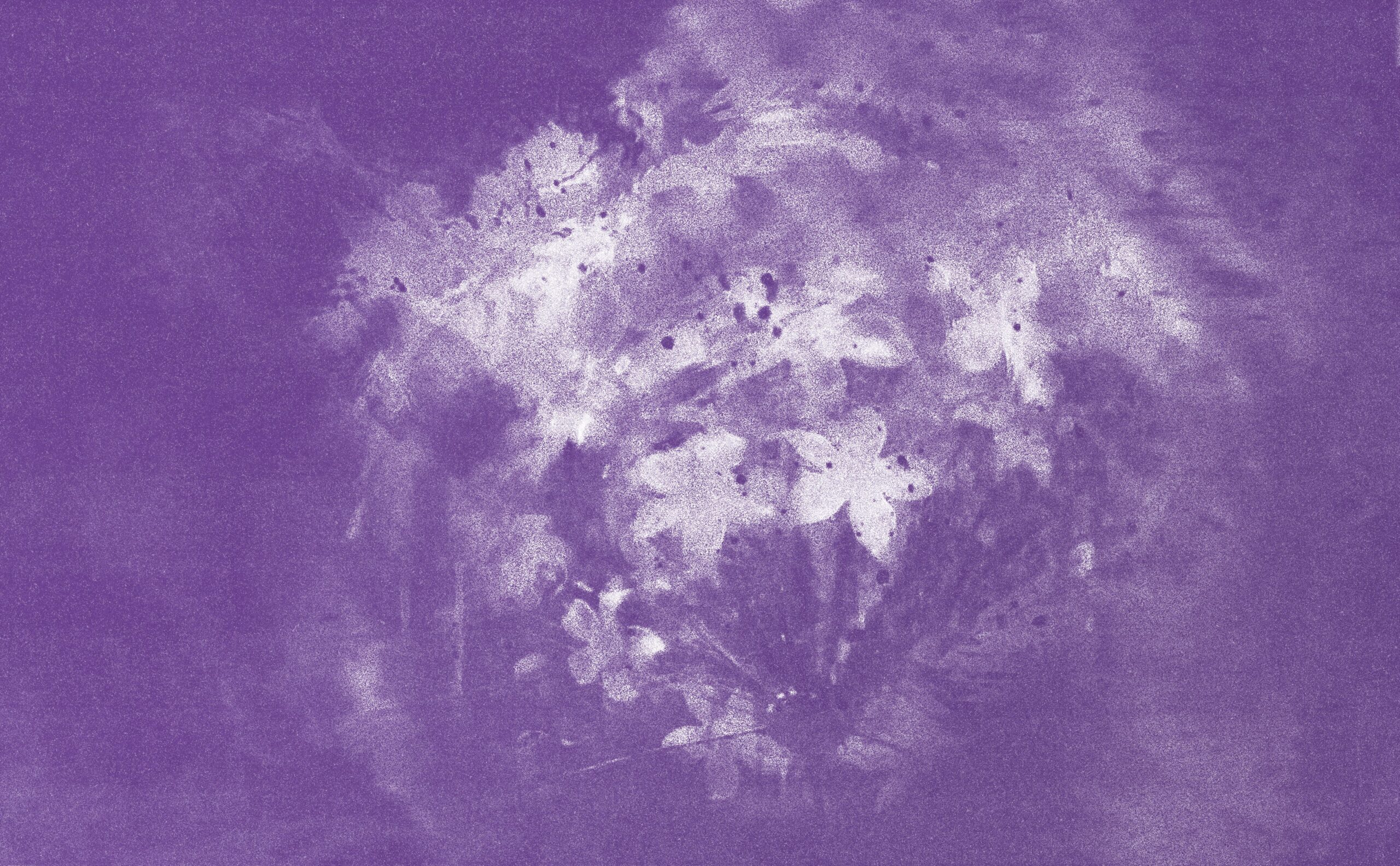La disciplina del posacenere
È il ricatto del dolore che artiglia Oria alla bocca. Le cuce le labbra con ami da pesca e dai buchi degli innesti il suo silenzio gronda latrati di sacramento disobbedito. Io cosa, posso sentirli. Mentre siede davanti a me per quarantacinque minuti a settimana nel Centro di Salute Mentale. Assume i farmaci con docile regolarità, genuflessa al processo di domesticazione al quale uomini e donne come lei ma diversi da lei annettono al dominio corrente gli esuli della società.
Alle quindici e trenta del giovedì entra, si siede, tace. Alle sedici e quindici lo psichiatra di turno, uomo o donna come lei ma diverso da lei, la saluta e l’accompagna alla porta. Nel mezzo, l’io cosa di Oria, che porta l’oro nel nome di Santa spagnola, è ferrigno lago liminare in cui lo psichiatra di turno, uomo o donna come lei ma diverso da lei, esercita il meretricio a suo modo, affondando pretesti nella broda impressionista delle piaghe. Prova a farne tracimare la violenza che annuncia la comprensione, che anticipa il perdono. Prova a sedurlo, o a violentarlo. Prova a ignorarlo, o a strattonarlo. Prova a succhiarlo, o a masturbarlo. Prova a blandirlo, o a esasperarlo. Glielo impone il lavoro per cui riceve uno stipendio a fine mese. Ma l’io cosa di Oria fumiga nebbia delusa e usurate inquadrature di palude: vitreo occhio destinato a guardare senza riflettere vorrebbe forse cedere, frammentarsi, incrinarsi ma non può.
Lo so perché mi somiglia.
Anch’io sono cosa, l’ho già detto. Cosa cedevole plasmata in altra cosa rafferma.
Sono DAS.
Pasta grigia e tossiche fibre di amianto, figlia di poeta combattente battezzata con la sigla del nome del padre: DArio Sala. Creta apocrifa, brevettata negli anni Sessanta del Novecento. Miscela sintetica, trastullo o impostura per decenni di scolaresche e di alienati mentali forzati all’espressione con la scusa dei lavoretti creativi. DAS, ubiquo assassinio commerciale destinato a desacralizzare l’incomunicabilità cristallizzando l’impulso vitale del corpo nel gesto impoetico di una genesi infeconda. Io, cosa cedevole plasmata in altra cosa rafferma, ho forma di tondo malriuscito, cavo per ospitare cicche. Sono banale come l’odio. Terraferma crepata dipinta di giallo nell’incontro non privo di erotismo con la setola di un pennello, ipotesi cosmologica di demiurgo psicotico inserito in un programma di recupero ormai quasi trent’anni fa del quale ho perso il destino. Io cosa, ordinata, disciplinata, disciplinatamente galleggio come una baracca tra le altre baracche del sistema. Io cosa di DAS ormeggiata da quasi trent’anni su una scrivania che nessuno spolvera. Insieme a me, un’altalena di fil di ferro, una palla portachiavi di cincillà sintetico, un punteruolo desiderante, la cartella clinica di un suicida.
Anche la strada è cose e io la vigilo dal punto d’osservazione di un’isola con quattro gambe, immobile, né superficie né abisso: la finestra mi mostra una civiltà che dondola, un muoversi lento di cuori tra i giunchi di uno stagno in cui tutto cambia affinché nulla cambi.
Così fuori come dentro, nella fissità silenziosa dell’io cosa di Oria sono il voyeur di altri voyeur. Una parte del visibile resta nel fuoricampo, sempre.
Chi è il sottomesso? Chi il dominatore?
Nell’inquieto movimento della sua anima sono il testimone di ciò che non conclude. Una parte del dicibile è inciso nel copione, sempre: si chiama violenza, qualunque forma le abbia assegnato il caso.
Se alla tua scorza tagliano un pezzo e poi ti lasciano amputato a largo del mondo, continuerai a vivere senza un pezzo perché nessuno avrà abbastanza pietà da ucciderti. Oria l’ha mutilata il compagno di sua madre; un poliziotto con una svastica tatuata sul culo che a quattro anni le ha insegnato a farsi cava per raccogliere i mozziconi corrotti delle carezze, le ha insegnato che la quotidianità è una rana scuoiata che serve a nutrire le ali delicate dell’amore, le ha insegnato che si può inghiottire ogni cosa senza vomitare. Lei ha imparato tutto e se non avesse affogato i pappagallini di sua nonna nella tazza del cesso nessuno l’avrebbe fatta ricoverare.
L’anima è un corpo infilzato.
Me lo ha detto un giorno, quando lo psichiatra di turno ha avuto un infarto e nella stanza siamo rimasti soltanto noi due; mi ha detto che quando era piccola sognava di fare la poliziotta ma la sua anima non le è stata fedele e lei ha dovuto ucciderla.