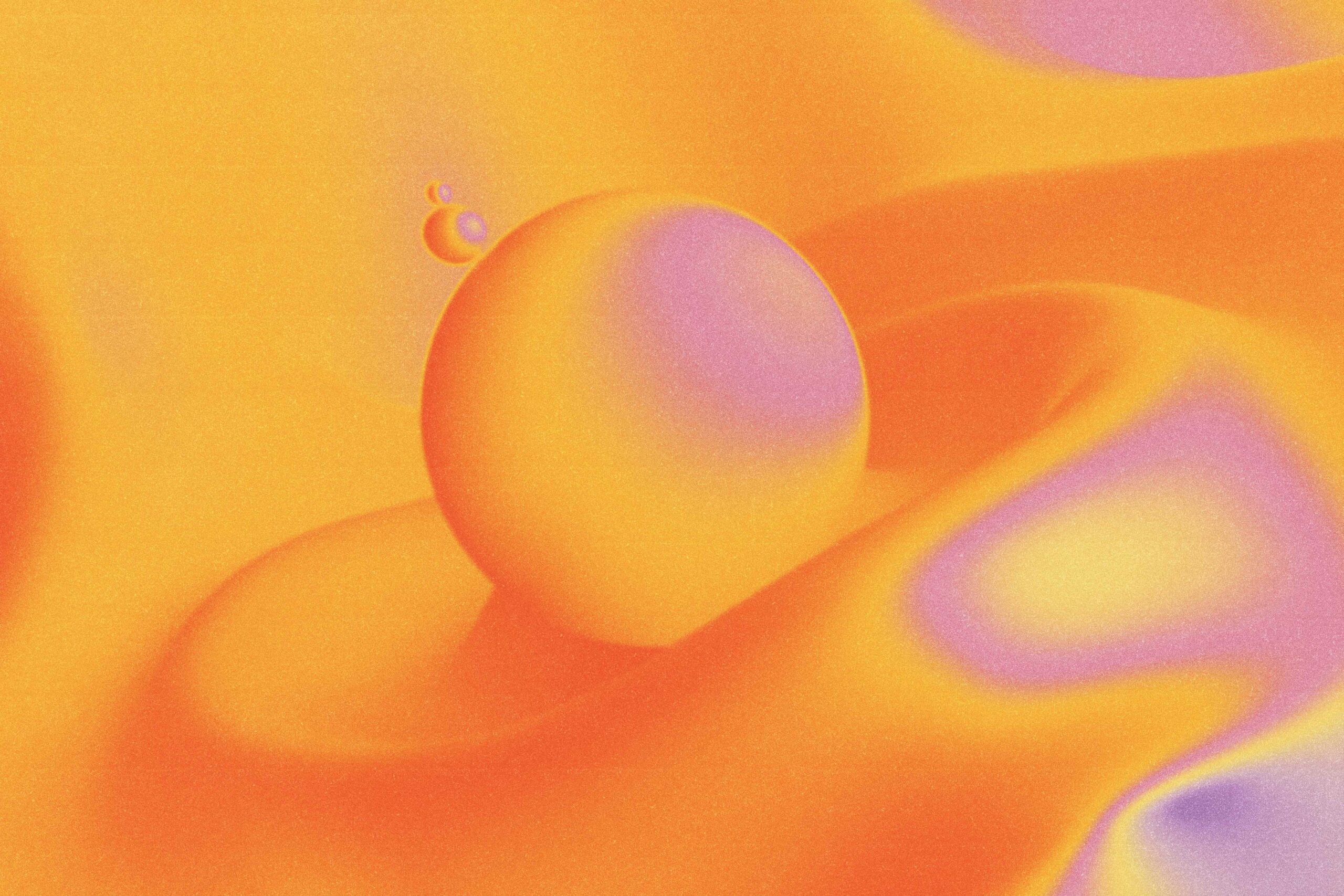La marmotta
Sono l’unico speziale del circondario e da tempo le mie giornate sono scandite da richieste perlomeno bizzarre. Quella mattina, per esempio, un vecchio pastore, vecchio quasi quanto me, si presentò alla mia capanna chiedendomi qualcosa che potesse curare la vista del suo unico amico: soffriva di un’irritazione cronica agli occhi, che lo aveva reso quasi cieco. Il vecchio riconduceva alla pigrizia la causa della malattia: rinchiuso da secoli nel cuore della montagna vicino al mare, gli occhi dovevano essersi atrofizzati, indeboliti fino ad arrendersi all’infiammazione. Quando chiesi di cosa si occupasse quel suo amico centenario, il vecchio rispose che faceva il gigante. Preparai allora un pentolone di acqua bollente e vi feci macerare alcuni arbusti di eufrasia e di camomilla.
Meno singolare fu la richiesta di una donna che nel pomeriggio reclamò un veleno che sterminasse i topi nel granaio, per poi pretendere – libera e invertita è la psiche umana – che la sostanza facesse effetto anche sulle streghe e sulle signorine che gironzolavano nel granaio e intorno al marito.
Poco m’importa da dove provenga la felicità del mio cliente, se gioisca per la morte della sua rivale di letto, o se svuoti soddisfatto litri di collirio nelle pupille del gigante. A me interessa vedere sul suo volto sollievo e appagamento. Me ne basta un accenno per goderne.
La sera mi fecero visita due emissari del Governo. Uno era grasso con la fronte lucida di sudore. L’altro era magro con un volto rugoso e volpino. Iniziò a parlare il grasso.
«Il popolo ha bisogno del suo aiuto», esordì con tono grave, come se dietro a lui ci fosse una folla ad attendere il mio responso. «Lo stesso popolo non deve sapere nulla».
«Non capisco», dissi allargando le braccia.
Intervenne allora il magro.
«Vede, negli anni ho compreso che la più grande opera del Machiavelli sullo Stato è la Mandragola. C’è tutto: il raggiro, la maschera, la finzione… il tutto a fin di bene, ovviamente. Ecco, quello che vogliamo da lei sono… mandragole. O un loro elettuario che faccia sorridere e che camuffi il volto del popolo, deturpato dall’amarezza e dall’ignoranza. Crede di esserne capace?»
«Posso tentare», risposi.
«Ottimo, e ha già pensato a qualche pianta?», chiese il grasso.
«Non ne ho in mente molte».
Abbassai lo sguardo e il grasso mi guardò severamente.
«Stia tranquillo», intervenne il magro, «noi abbiamo bisogno di maschere, apparenze, finzioni. Prendiamo per esempio la felicità, un buon punto di partenza anche per lei, credo. Ecco, non la pretendiamo, ci basta un suo accenno. Un sorriso sopra due occhi luccicanti: a noi uomini di Stato basta e avanza. Chiediamo troppo?»
Le parole dell’uomo mi restituirono un po’ d’animo. Gli proposi allora di ripassare il mese dopo, promettendo che avrei rimediato qualcosa.
Furono giorni intensi, quasi folli: testai più di un centinaio di piante, le loro combinazioni in decotti, succhi, preparati. L’incombenza era complessa ma non potevo ignorare un vantaggio: non ricercando la realtà, ma solo il suo abito, ovvero la posa e l’apparenza, avrei potuto sperimentare le mie preparazioni senza badare al piacere, al dolore, alla disperazione delle mie cavie. Non mi servivano le loro impressioni, non dovevo parlare con loro, non chiedevo un volto, mi bastava un muso. Iniziai iniettando dell’iperico a un porcospino, il cui corpicino prese subito a tremare per poi paralizzarsi; lo gettai fra i castagni ignorando se fosse morto o meno. Un istrice con lo stomaco saturo di foglie di rodiola e belladonna prese a rimbalzare fra le pareti della capanna finendo stecchito. Un giorno rincorsi uno scoiattolo a cui avevo dato da bere una pappa di miele, aconito e cimicifuga: fuggito dalla capanna, aveva raggiunto il ramo di un albero e lì aveva perso l’equilibrio precipitando infine al suolo. A dire il vero ebbi l’impressione che la caduta non fosse stata fortuita, ma anzi cercata con la poca consapevolezza che gli restava.
Trascorsi giornate indecifrabili durante le quali lo sconforto ebbe comunque sempre la peggio sulla stanchezza. Fu solo per noia che raccolsi il Finocchio d’Acqua: lo conoscevo da tempo, ma la sua statura media e i suoi piccoli pallidi fiori anonimi mi avevano lasciato talmente indifferente da tirare dritto a ogni sua apparizione. Dopo un mese d’insuccessi, un tentativo anche con quel poco invitante prezzemolino era lecito. Pestai al mortaio il suo fiore e il suo gambo, e li feci macerare con del vino per tutta la notte, ricavandone una ricca colazione per una marmotta che, chiusa in gabbia, non beveva né mangiava da due giorni. Mentre mi apprestavo pigramente a rimettermi al lavoro su altre ricette, avvertii prima l’osceno rumore delle fauci sul pasto, poi un silenzio operoso. Mi voltai verso la marmotta. Era ritta nella gabbia, con l’occhio un po’ languido forse per colpa del vino, ma con un sorriso sul muso. Mi precipitai su di lei, la presi in braccio, la accarezzai, la feci zampettare per la capanna. Sembrava stare bene. Ci giocai, prima con delicatezza, poi con decisione fino a immobilizzarla, di tanto in tanto, stringendo il suo corpicino definito da un mucchietto di ossa. Si stava innervosendo, ma mi sorrideva. Infine, mi toccò a malincuore torturarla, e, nonostante la sentissi soffrire orribilmente fra le lame e i ferri arroventati, scoprii con gioia che continuava a ridere. Che attrice, che interprete, che diva! Subito dopo la uccisi, non volevo provocarle altro dolore. Mi concessi il vezzo di sviscerarla e imbalsamarla, per conservarla sorridente vicino a me, in ricordo del mio successo.
I due uomini tornarono un paio di giorni dopo. In un misto di apprensione e di eccitazione, li feci partecipi del mio trionfo descrivendo la fatica con cui avevo conquistato la felicità della marmotta che vigilava su di noi dallo scaffale più alto. Non c’è bisogno di dire che mi riempirono di lodi, soprattutto il magro.
«Che grande contributo. Un compito tragico e anche comico, ma soprattutto necessario», mi disse come se lodasse non il mio lavoro, ma il mio presunto sacrificio. Se ne andarono soddisfatti con la ricetta che gli avevo preparato, e con la raccomandazione di scovare altre maschere e altri travestimenti.
Questo tre settimane fa. Da quel giorno tento di lavorare su nuove piante e formule che possano mimare lo sconforto, la rabbia, la paura, il disgusto, ma i risultati sono insoddisfacenti. Nessuna delusione però mi abbatte perché a vegliare sul mio lavoro c’è la mia nuova amica. Mai il suo sguardo indulgente mi abbandona. Mai vedo del biasimo nei confronti della pigrizia che mi prende a poco a poco, dopo le lusinghe dei due uomini. Ad alimentarla sono le notizie che mi giungono: mentre qualche settimana prima gli uomini si trascinavano all’alba nei campi con una smorfia di sofferenza, ora è palese la soddisfazione sui loro volti. Anche i fabbri squassati dal calore delle fornaci sembrano aver riacquistato la spensieratezza, e i falegnami, indifferenti al pericolo delle lame e delle seghe, ridono entusiasti senza traccia né di paura né di prudenza. Molti hanno notato come il canto delle lavandaie sia sì il medesimo, ma grazie alle bocche rilassate ha acquisito un’armonia dolce e gaia. Persino le massaie sembrano non soffrire più di quella malinconia che può sorgere da una vita solitaria, stretta fra quattro mura. La mia cliente, per esempio, ha continuato a chiedere il suo veleno per topi ma con una contentezza e una serenità tali che l’ombra di un possibile crimine nei confronti delle rivali è definitivamente scomparsa dalla mia mente. Quando poi ho visto i condannati a morte scambiarsi sguardi languidi con i rispettivi boia, con amarezza e orgoglio ho ricordato il coraggio della mia amica davanti al martirio e all’omicidio da me perpetrati. E in tutto questo, i governanti, e io con loro, non possiamo che gongolare nel tepore del successo, quando questo non si accende nella vampa della fantasia: di tanto in tanto mi sono infatti immaginato come un demiurgo che, accogliendo lo spirito dello Stato, ha fatto della mia affezionata un messia di gioia e di sacrificio.
Ieri sera, mentre me ne stavo sdraiato fra le felci a godermi gli ultimi raggi di un sole pallido, vagheggiando un’umanità a imitazione della marmotta, ho incontrato nel bosco il vecchio pastore. Camminava spedito, per quanto poteva, come se fosse inseguito da un branco di lupi.
«Dove vai di corsa?»
«Scappo», ha risposto con un filo di voce.
«Dal tuo gigante?»
«Dalla legge. Hanno iniziato a uccidere i vecchi perché inutili»
«Dici follie!»
«Non lavorano, non producono e allora li uccidono. E la cosa buffa è che i vecchi muoiono felici. Gettati giù dalla rupe nel mare, cadono col sorriso, mi ha detto il mio amico. E così i governanti si giustificano. Avete visto? Muoiono felici perché muoiono per lo Stato. Sanno che è un’azione giusta. Ma io non ci credo».
L’ho visto allontanarsi lungo il sentiero. Ho provato irritazione per quel vecchio pastore pazzo. Mi ha messo di cattivo umore perché mi ha ricordato quanto più vecchio sono di lui. Sono tornato alla capanna e ho cercato con lo sguardo la mia marmotta. Il suo largo sorriso aveva un che di meno confortante, ma qualcosa di più arguto e di velenoso. Mi sono gettato a letto e dopo un sonno agitato, adesso che è l’alba, dei colpi battono alla porta. Apro gli occhi e incontro lo sguardo della bestia imbalsamata. Le pupille dilatate. La smorfia oscena di chi prova un piacere occulto.
Arrivano altri colpi e le urla.
«Dobbiamo portarla con noi»
«Perché? E dove?»
«Alla rupe, vecchio. Per farti vedere il mare. È bello lì».
Le guardie sfondano la porta e mi prendono, l’ultima cosa che vedo è il risolino deforme della marmotta.