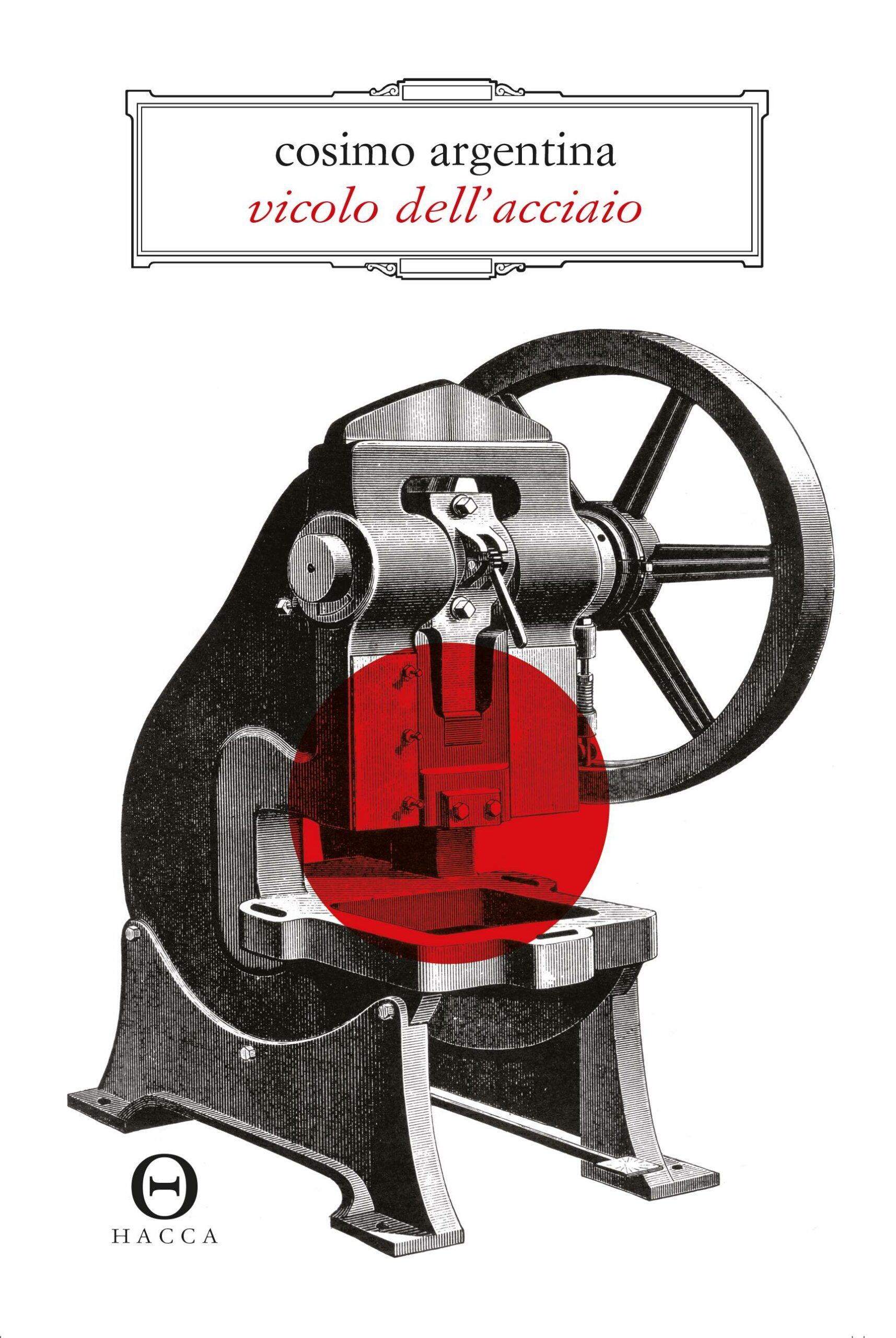La Taranto d’acciaio di Cosimo Argentina
La ripubblicazione di un libro fuori catalogo è spesso un evento fausto, tanto più quando, come nel caso di Vicolo dell’acciaio di Cosimo Argentina, il libro in questione racconta una storia di attualità ancora assordante. L’Ilva, mostro siderurgico e tentacolare cui ogni tanto vengono dedicati fugaci servizi al telegiornale o trafiletti riempitivi che pare servano solo a farlo tornare più alla svelta nel dimenticatoio, è protagonista indiscussa del romanzo di Argentina, insieme a una Taranto squartata, divisa in quartieri cui si appartiene per nascita e da cui si esce con circospezione, se possibile accompagnati da qualche ‘mbà fidato che ci guarda le spalle. Il diciottenne Mino Palata, ritratto dell’autore da cucciolo, è un “via Calabria” orgoglioso e consapevole di far parte di un circolo umano derelitto, composto da uomini-gechi che dopo il turno in prima linea nell’acciaieria si addossano al muro davanti al bar di mest’Arture e tracannano una birra via l’altra, e da donne dimesse, sconfitte insieme ai propri compagni, abbracciati a una croce che porta il pane ma costringe a una vita di rinunce e terrore dello strappo repentino; il mostro esige sacrifici, e i prima linea sono carne da macello che presto o tardi l’Ilva abbatte: con un tumore che consuma, con una trave che sfracella, con alcolismo, depressione, persino follia. L’umanità tratteggiata da Argentina, per la maggior parte del tempo, sembra uscita da una scenetta di Ciprì e Maresco e, man mano che la storia procede, appare sempre più chiaro che Taranto non lascia spiragli di niente, che da Taranto non esiste fuga, e che ogni tentativo di riscossa è o fallimento o posa o macchietta.
Il dato più interessante di Vicolo dell’acciaio, un romanzo senza dubbio di denuncia, è tuttavia la lingua: Argentina svela le brutture della periferia tarantina con una prosa biomeccanica e scintillante, attualissima, che mescola italiano e dialetto evocando carne e acciaio, sudore e fosfati, cromature e afrore, tutto mescolato su un palcoscenico dove si ha l’impressione che i borgatari pasoliniani abbiano incontrato il nadsat, la neolingua dei drughi di Arancia meccanica e le atmosfere postmoderne de “Le luci della centrale elettrica”: «Il nostro mondo – dice Mino – è d’acciaio lavorato a freddo e a caldo. Il nostro mondo è fatto di laminatoi, cokerie, bramma, tubi, elettrozincatura, ricottura statica e compagnia cantante… ogni tanto un via Calabria 75 ci lascia le penne. Lo mettiamo in conto. […] Ma il lutto qua non lo senti come qualcosa di tenebroso. È una presenza incombente che preesiste alla tragedia».
Forse allora la vera tragedia dei protagonisti di Vicolo dell’acciaio – al netto dei pochi che vanno via o provano a ribellarsi allo stato delle cose – è proprio l’accettazione prona della propria condizione esistenziale, del destino che sembra già scritto: lo capisce Mino, che deride gli attivisti, non riesce a trovare riscatto negli svogliati studi di giurisprudenza e la cui unica valvola di sfogo è la scrittura di racconti dove la violenza esplode senza motivo, ai danni di personaggi che, come lui, sono vittime di una realtà che toglie il respiro e la speranza.