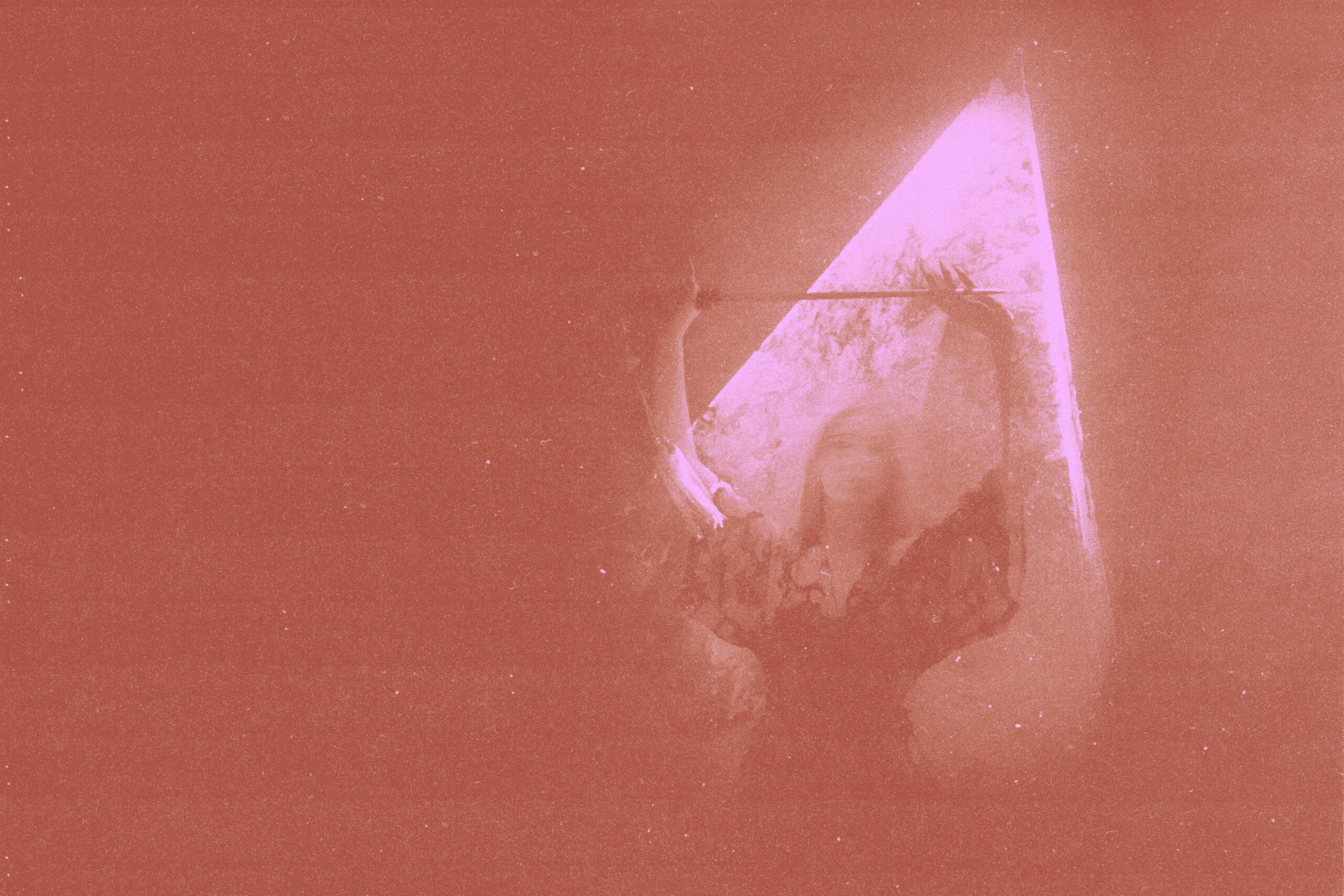Colpa
Ad una ad una si spensero le luci della compassione e con esse il calore della cura. Le fiammelle delle candele ormai estinte saturarono l’aria di indifferenza e di lutto. Saldava le mani emaciate al viso per proteggersi gli occhi da qualcosa che la perseguitava. Era lontano il tempo della prima volta in cui disorientata tagliava la stanza da un capo all’altro. Loro l’avevano vista, sbigottiti. Correva ciecamente sbattendo come un insetto contro i vetri. Cosa le era rimasto di una vita? Delle dita che, nella vacuità degli spazi, disegnavano i vaghi contorni del dolore. Il ronzio perpetuo ristagnava nelle orecchie come lo stridore di una sedia trascinata, a consumarle dall’interno le membrane dei timpani fino al punto di deflagrazione. Urlava dimenandosi per strappare con le unghie il telo di plastica che sopprime ogni respiro. Il tormento delle Erinni la raggiunse, impose la condanna e con il suo segno la marchiò. L’impronta sempre più densa della colpa le scavò profondamente il viso con lacrime che correvano silenziose e senza volontà. Si annegava nelle acque torbide di un pensiero che, autopensatosi, si sviliva. Insieme a questo, tutte le cose precipitavano nel baratro della mediocrità, mentre lo spirito si contorceva nel risentimento verso se stesso. La quotidiana cerimonia della commemorazione dell’errore la invitava a distribuire le carte di un gioco masochistico senza condizioni, senza vincitori. I salmi scivolavano attraverso le labbra screpolate, appena dischiuse, tese ad invocare una redenzione. L’imputato era il suo essere stato evoluto inesorabilmente in persecuzione. L’irrevocabilità del passato e delle azioni qualificavano il presente essere al quale – era stato deciso – doveva essere strappato il lume e il suo ancóra. Avanzava nella moltitudine con la fatica di una parte biologicamente viva – per quanto ancora? – che si fa carico della parte morta. Non sono degna di intrecciare le mie dita con altre nella stretta di una solidarietà dolente, ma di’ soltanto una parola ed io sarò salvata. Si consumava nella sospensione irrisolta tra l’imposizione di una condanna e un desiderio di salvarsi. Vagava negli spazi in un pianto dirotto, entrando con tutto il corpo nella disperazione dell’anima, perché si può comprare l’espiazione vendendo e consumando la carne; ma in questo moto circolare non agisce alcuna forza centrifuga, solo l’inganno della logica: la rivelazione tarda, la redenzione si nasconde poi si dissolve. Strepitava, delirava, si sfiniva. Ai margini del tempo del riscatto, scavava il fosso per inchiodare i piedi al solitario centro della terra: anche lì, illusorio asilo, il terrore delle trombe efferate della caccia la assediava e si scarnificava con parole feroci. Incattivita e spietata, si paralizzava nel rifiuto del soccorso: retrocedeva, stendeva le mani anchilosate, per fermarne l’avanzata, contro una sfumata idea di amore che tornava a farsi viva dopo aver straziato. Dopo il rigetto l’ostinazione, ma la disabitudine all’accoglienza la incatenava alla consuetudine degli abbandoni senza ritorno e ai ciclici moti di espulsione. Nell’umidore del fondo torturava i capelli un tempo vermigli, la baccante: era lei stessa la folla imbarbarita che la additava e che la investiva calpestandola. Non sono degna di bagnare con lacrime mani che raccolgono e asciugano, ma di’ soltanto una parola ed io sarò salvata. Transitava nel tempo avvertendosi come ingombro superfluo o nodo che si nega nel tentativo di districarsi da ostinati lacci interiori, antichi. Quanto di quel senso di colpa aveva un’origine negli atti del reale e quanto di esso era frutto di un’allucinazione proveniente da un tempo che la precedeva? Entro quali limiti si consumava un dramma soggettivo e dove, invece, il confine poteva estendersi ad una condizione universale? L’intuizione di una colpa primordiale collegata al solo fatto di vivere si rese presente alla coscienza, ne aggravò il peso e il suo precipitare verso la disgregazione. Quando la favilla dell’Essere fu prossima ad incenerire, il logoramento determinò una mansuetudine che fu ritenuta segno incontrovertibile di guarigione. Le palpebre abbassate, il raccoglimento in una tristezza silente e la calma catatonica apparvero per quelle che realmente non erano. Gli occhi del mondo si erano persino accontentati della magrezza e tutto, anche la follia che ormai si esprimeva con l’afasia, fu rovesciato nel meccanismo naturale e cieco delle cose. Cadde il drappo di velluto soffocante dell’assuefazione al dolore e in quell’abitudine si spense.