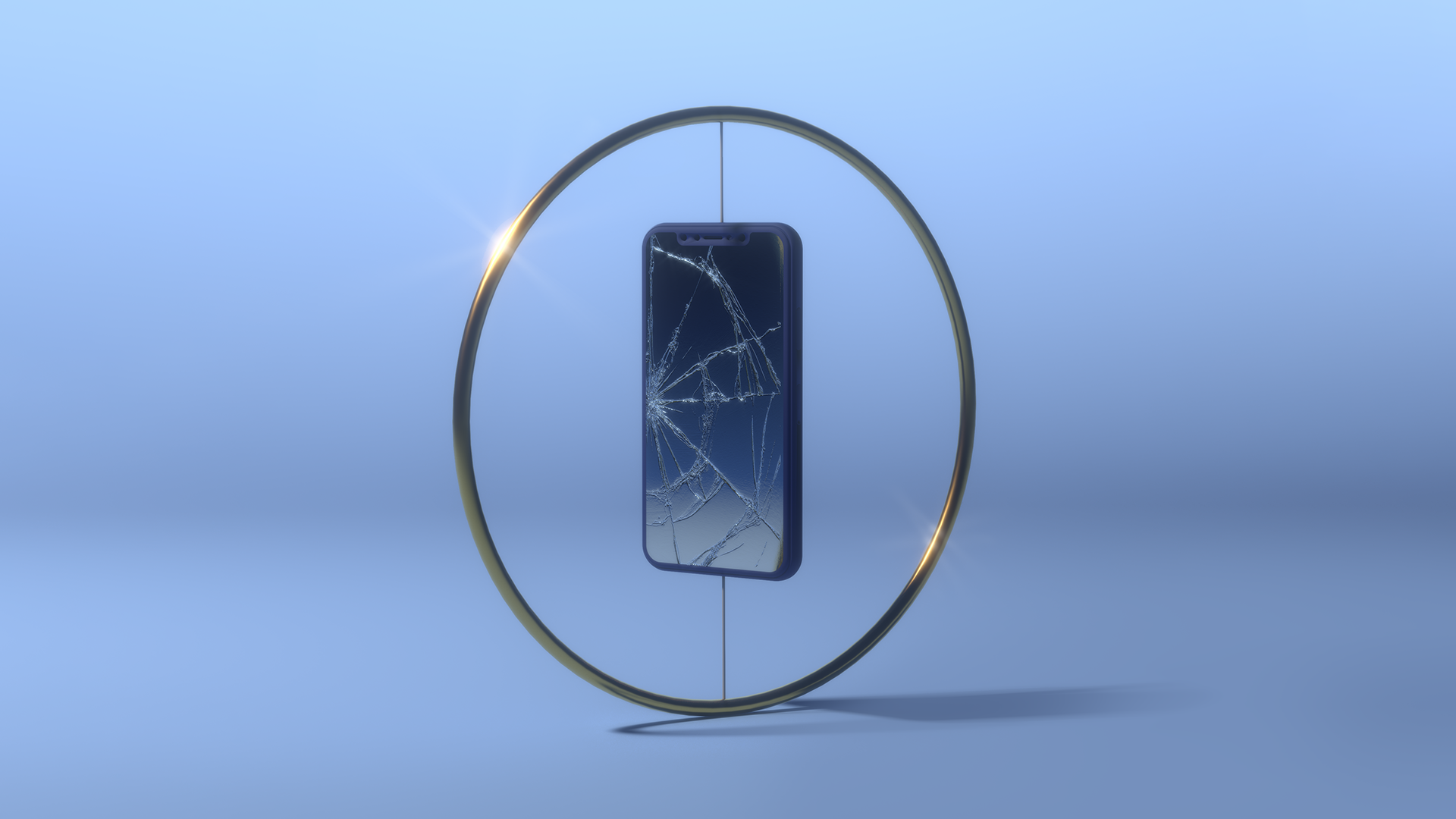IAD e Covid, una miscela pericolosa
A volte alcune esperienze collettive riescono ad accelerare dei fenomeni già presenti nella società. Solo quaranta anni fa i pedagogisti si dannavano per capire le conseguenze della fruizione televisiva sulle nuove generazioni. Proprio a Napoli, all’Università Federico II, la prof.ssa Clementina Gily mise a punto una ricerca sulla Dieta televisiva, per formare genitori e docenti all’uso critico e creativo del mezzo televisivo e contrastare così nei ragazzi e nei bambini alcune conseguenze relative all’apprendimento e alla socialità. Ancora prima, circolarono numerosi saggi sulla nascita del bambino audiovisivo, sulla crisi dell’era gutemberghiana, sulle nuove dipendenze relative alla TV. La mia tesi di laurea si intitolava “Davide e Golia nell’era della multimedialità” e fu discussa con il professor Abruzzese, ordinario di Sociologia delle comunicazioni di massa. Un bambino che sfida un gigante inattaccabile: ecco come percepivo la relazione tra i giovani e il grande colosso tecnologico. Si parlava allora di prevenzione attraverso le misure compensative, legate alla capacità di socializzazione delle agenzie formative come scuola e famiglia. Iniziammo a progettare laboratori didattici per la fruizione critica dei contenuti che veicolava il mezzo televisivo. Eppure mai potevamo prevedere l’aumento esponenziale di questo tipo di dipendenza in altre forme.
Prima della pandemia, sui social network e nelle riviste specializzate, si parlava spesso della dipendenza dai selfie e dal cellulare. Altro indizio di questo degrado collettivo verso la società dell’immagine, in cui la percezione del vuoto esistenziale è colmato dal rispecchiamento nell’immagine digitale. La dipendenza da Internet, in inglese Internet Addiction Disorder (acronimo IAD), è un disturbo da dipendenza legato ad utilizzo intensivo e ossessivo di internet in tutte le sue forme, dalla navigazione sui social alla visualizzazione di filmati al gioco online. Il termine è stato coniato dal medico Ivan Goldberg nel 1995, il quale aveva per primo diffuso in rete un questionario diagnostico. Nonostante l’intenzione puramente ironica del questionario, la sua diffusione riscontrò un forte interesse. E si formulò così la teoria dell’esistenza della nuova psicopatologia del millennio. La sindrome di internet addiction comprende una vasta categoria di comportamenti compulsivi in cui il soggetto trae piacere dall’acquisizione immediata di oggetti o dall’aspettativa di vincite in denaro facili e veloci. Appartengono a questo tipo di dipendenza il gioco d’azzardo patologico, lo shopping compulsivo e l’abuso di siti e-commerce. Queste condotte compulsive diventano in breve tempo del tutto fuori controllo, causando gravi problemi finanziari, relazionali e lavorativi nella vita del soggetto. L’utente arriva a perdere importi eccessivi di denaro e a focalizzare tutta la sua attenzione nell’arco dell’intera giornata.
Inoltre a causa della ricchezza dei dati disponibili sul World Wide Web si determina un nuovo tipo di comportamento compulsivo, che riguarda la navigazione e l’utilizzo delle informazioni presenti in rete. Le persone affette da questo disturbo di tratto ossessivo-compulsivo trascorrono sempre maggiori quantità di tempo nella ricerca e nell’organizzazione di dati requisiti dal Web. Tale dinamica comporta spesso la riduzione del rendimento lavorativo e l’insorgere di difficoltà relazionali.
Un effetto di queste difficoltà relazionali è il procedere verso un disturbo antisociale di personalità, caratterizzato dal disprezzo patologico per le regole e le leggi della società e del mondo circostante, dall’incapacità di assumersi responsabilità e dall’indifferenza nei confronti dei sentimenti altrui.
La pandemia da Covid-19 e le misure preventive di isolamento sociale stanno portando inevitabilmente verso un uso compulsivo dei mezzi digitali. La connessione informatica digitale non solo è aumentata ma è fortemente richiesta per la Didattica a Distanza, per lo Smart Working, per la miriade di webinar che si stanno moltiplicando in rete. Una richiesta che vuole compensare la chiusura di tutti gli spazi professionali e di formazione in presenza. Purtroppo dobbiamo individuare i limiti di questa amplificazione del mezzo digitale.
Oltre la dipendenza eccessiva dai mass-media, è possibile rintracciare un rafforzamento della deriva narcisistica autoreferenziale, che passa dal moltiplicarsi degli influencer sul web, e delle esposizioni pubbliche con ogni finestra possibile sui social network. Se prima eravamo dipendenti dall’uso passivo del mezzo televisivo, ora possiamo diventare dipendenti dall’uso “attivo” dello schermo. Ora siamo noi dietro lo schermo e l’ossessione quotidiana della visibilità digitale diventa una forma di bulimia psicologica insaziabile. Il narcisismo digitale ci rende permeabili a questa crescente necessità di mostrare il nostro viso, di stare al centro dello spettacolo multimediale, di sentire come urgenza quotidiana l’apparizione fantasmatica nella vetrina digitale, per superare lo smarrimento, colmare il senso di vuoto e allontanare così la minaccia proveniente da questa situazione pandemica globalizzata.
Ma la dipendenza da internet e il narcisismo digitale possono pericolosamente mescolarsi ad un altro disturbo della socialità: l’afefobia, la paura del contatto. La parola afefobia, data dall’unione delle due parole greche “ἄπτω” (toccare) e “φόβος” (paura), indica la paura inconscia di una possibile violazione della sfera intima. Il contatto fisico riveste un ruolo primario nella vita sociale; alla nascita è il senso più sviluppato e contribuisce in maniera determinante all’evoluzione del pensiero, del cervello e allo sviluppo dei legami interpersonali. Spesso la ritrosia dimostrata da alcune persone al contatto fisico viene scambiata con la timidezza. L’afefobia risulta evidente solo quando i sintomi cominciano a diventare più gravi e la paura del contatto fisico comincia ad influenzare pesantemente la vita e le scelte del soggetto. La paura del contatto fisico si esprime essenzialmente con il disagio e la repulsione ingiustificata e incontrollata del contatto con le persone. Spesso, le persone affette da afefobia temono il contatto fisico per la paura di essere contagiate con germi e batteri. Quando si trovano in una situazione considerata a rischio cominciano ad avvertire un forte disagio, a tremare e a sudare. Nervosismo, angoscia, senso di soffocamento sono le sensazioni che solitamente assalgono chi sfugge il contatto fisico. Possono verificarsi episodi di tachicardia, problemi di respirazione ed attacchi di panico.
Sentire che l’altro ha superato la distanza di sicurezza e magari ci sta abbracciando spontaneamente, anche solo per dimostrare riconoscenza, ci crea disagio, imbarazzo, fastidio, malessere: è come sentirsi nudi, senza protezione. L’istinto porta ad attuare un meccanismo di conservazione detto di “evitamento”, ovvero allontanarsi da tutte le situazioni in cui si potrebbe entrare in contatto fisico con altre persone. Ecco, ora noi siamo spinti dalle indicazioni della prevenzione sanitaria nazionale a praticare ogni giorno questo evitamento: si potrebbe parlare di afefobia sociale.
Dobbiamo essere consapevoli del rischio che possiamo correre, e sapere che avremo bisogno di un tempo per riprendere l’abitudine al contatto fisico con gli altri. Toccarsi e abbracciarsi sono modalità sospese oggi ma non per sempre. Dobbiamo essere vigili nel non diventare ostaggio di questa paura, sapere che si tratta di una astensione volontaria temporanea. E lavorare sul nostro sistema immunitario “culturale” basato sul benessere psicofisico, sull’attenzione verso i nostri talenti, verso ogni attività creativa che ci fa star bene. La realtà multimediale altamente raffinata dalla tecnologia informatica digitale non è la realtà, è una sua rappresentazione mediata. L’arte e la letteratura sono incontri con le persone nella loro interezza, corpo mente e anima. Ogni incontro è profonda alchimia, è una trasformazione profonda del nostro RNA. Non è solo immagine specchiata. Ricordiamoci di non perdere questo tesoro, siamo e rimaniamo essere umani. Non favoriamo questa mutazione transgenetica verso degli ologrammi che ci ingannano.
Ricordiamo che l’abbraccio è l’unità di base della nostra vita affettiva, tanto da essere considerata una terapia capace di riequilibrare corpo e emozioni. Lía Barbery nel suo libro “Il linguaggio degli abbracci” spiega in modo dettagliato i suoi laboratori di psicoterapia. Vari studi dimostrano che quando veniamo abbracciati il nostro corpo libera endorfine, degli ormoni che ci trasmettono una sensazione di piacere ed allegria, ossitocina, che provoca benessere, e deidroepiandrosterone (DHEA), l’ormone della gioventù. Insomma: un abbraccio ci fa sentire amati, e questo incide positivamente sul nostro stato emotivo e fisico, risollevandoci e rendendoci più felici. Non dimentichiamo questa grande risorsa che abbiamo e che dobbiamo recuperare, appena usciremo da questo brutto momento.