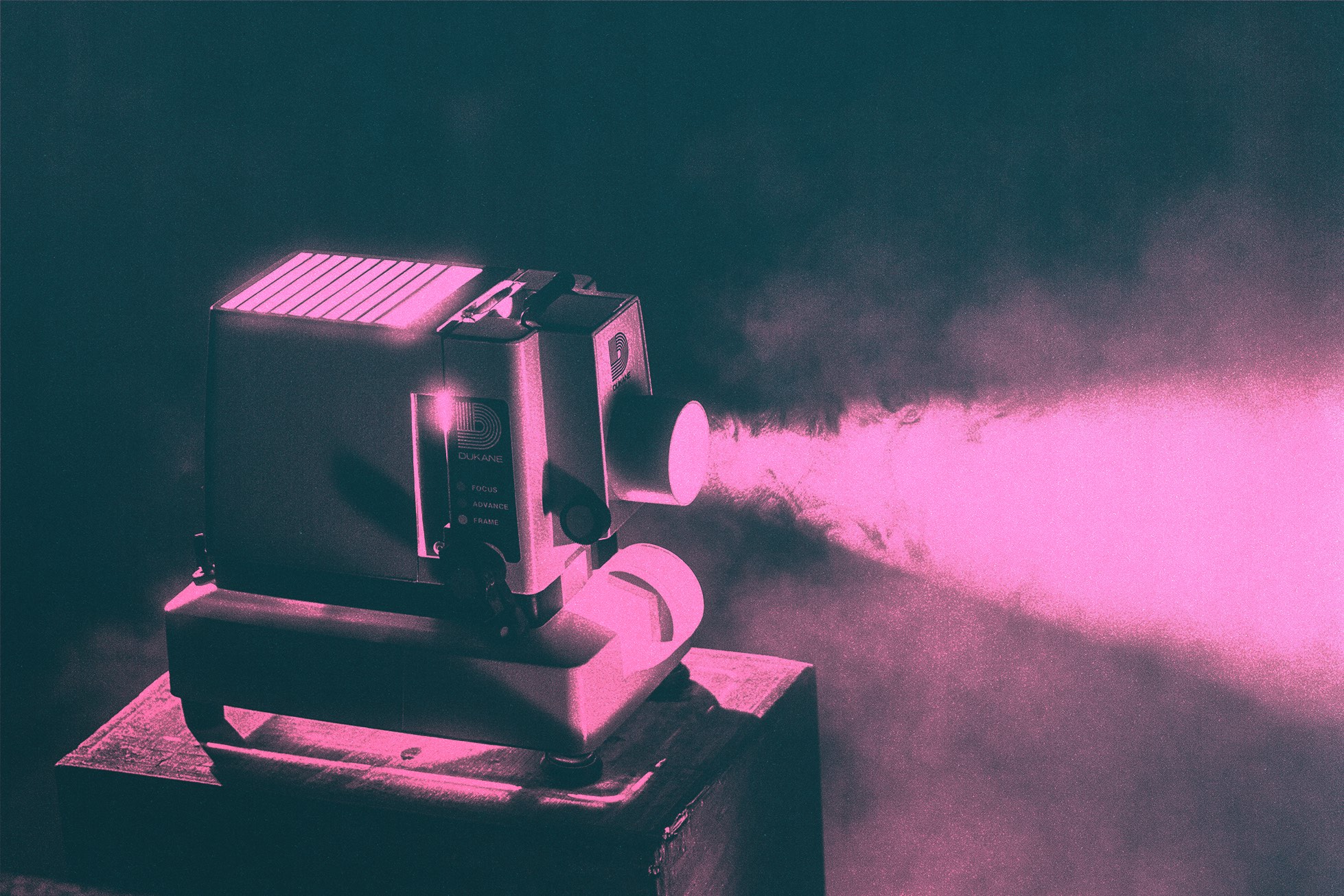Il premio incorniciato
A Milano c’è una piccola sala che condivide l’ingresso con una parrocchia locale. Vi si accede tramite un cancello in ferro con una grossa croce e, successivamente, una porta di legno anni Sessanta. Dietro il banchetto del bigliettaio-factotum c’è qualche poster, delle lucine di Natale (siamo in periodo) e pochi pacchetti colorati di patatine o caramelle. Alzando ancora di più lo sguardo c’è incorniciato il Biglietto d’Oro, ovvero un riconoscimento che l’associazione degli esercenti dà alle sale più frequentate d’Italia, in base a diverse categorie. Seicento chilometri più a sud, nel rione Trastevere di Roma, fra sampietrini e turisti molesti, c’è un cinema ben più moderno, aperto da molto meno. Anche loro il riconoscimento l’hanno vinto due volte, passando dal proiettare gratuitamente film in piazza a mettere su una delle realtà culturali più interessanti della Capitale.
In entrambi i casi, seppur con le dovute differenze, c’è qualcosa che stride, un ossimoro latente, un successo (apparentemente) inspiegabile. Per chi è nato in quel limbo che oscilla fra gli anni Novanta e i primi del Duemila, l’idea di cinema coincide perfettamente con i multisala rumorosi dove il pavimento appiccicaticcio in linoleum (o, peggio, in finta moquette) lascia un campo di battaglia sotto le suole delle scarpe. Chi aveva da poco salutato le sale di quartiere era con piacere approdato alla modernità. Lo spettatore, finalmente, poteva passare minuti interi in contemplazione del cartellone prima di palesare la propria convinzione al bigliettaio. Una rivoluzione rispetto alla realtà che abbandonava, dove non aveva senso chiedere un biglietto proprioperquelfilm, tanto c’era solo quello.
Ritornare oggi nello stesso multisala, magari con l’intonaco sbiadito e con la porta automatica che non funziona dal Natale precedente, significa trovare la biglietteria sbarrata, e più avanti un barista svogliato che – alla mattina, quando si sveglia – si chiede perché esista quella gente maledetta che rifiuta il biglietto online. I luoghi di aggregazione di ieri sono le cattedrali nel deserto di oggi, detta in breve. Chi può prova a reinventarsi, magari riducendo i posti e proponendo un’esperienza premium (sic), chi non può si accontenta degli ormai rari blockbuster. E, allora, perché oggi si preferisce tornare da quello stesso esercente di trent’anni prima che continua ad avere soloquelfilm in cartellone?
Intanto perché è l’unico ad aver mantenuto un cartellone in città. I centri commerciali in periferie cementificate raggiungibili solo in auto sono uno spiritoso anacronismo nel mondo delle “città in 15 minuti”. In secondo luogo perché, 99 volte su 100, soloquelfilm è un film bello. E se non è bello, è particolare. E se non è né bello né particolare, è stato scelto perché l’esercente di quartiere conosce – come il prete – i vizi e le virtù della sua gente, gusti artistici compresi.
Nelle sale di zona, dove i QR Code sono tecnologia aliena e i biglietti in carta fanno ancora quel bellissimo trac quando staccati lungo la linea tratteggiata, il cinema continua a vivere in quanto arte popolare: senza paillettes e sedili reclinabili con poggiapiedi.
A capirlo, volente o nolente, è anche la distribuzione, causa di molti dei mali dell’industria cinematografica italiana. Se i grandi studios non trovano più conveniente distribuire in sala – ormai ognuno ha la sua luccicante piattaforma streaming – i piccoli trovano nel monosala e nel cinema di quartiere il luogo ideale in cui proporsi a un pubblico in carne ed ossa. Persino gli eventi per la stampa, una volta caratterizzati da buffet luculliani captatio benevolentiae causam, si stanno trasferendo nei centri urbani, in sale a cui, fino a poco tempo fa, i distributori rifiutavano di vendere persino i prodotti di seconda visione. Chi ha in catalogo i pochi film non strozzati dalle finestre di distribuzione, ovvero il periodo di “esclusiva” che le sale hanno rispetto allo streaming, trova un pubblico educato (in senso filmico e non), disposto a spendere qualcosina in più per vedere l’ultima proposta del distributore. O della Quinzaine, di Berlino, di San Sebastián.
La causa ultima e prima del fallimento del multisala sta proprio nel non aver saputo (o voluto) educare lo spettatore, dato che l’industria dell’intrattenimento si accontenta unicamente di riempire le casse il più a lungo possibile. La pandemia, la scarsa scelta di titoli disponibili e il generale intorpidimento culturale del Paese hanno dato solo il colpo di grazia a un sistema che, prima o poi, sarebbe deceduto per cause naturali. Si chiede lo spettatore: perché abbandonare il divano, la televisione 4K e la piattaforma che ha già in evidenza il titolo adatto al tuo mood? Quasi profetico era Nanni Moretti, che in Caro Diario irrideva tutti quelli che vivevano fra “l’odore di tute indossate al posto dei vestiti, un odore di videocassette, cani in giardino a far la guardia e pizze già pronte dentro scatole di cartone”. Lo stesso Moretti che, da esercente, ha vinto nel 2021 il riconoscimento di cui prima con il Cinema Nuovo Sacher, uno storico monosala trasteverino.
La differenza è sconcertante: oggi un tipico multiplex valorizza la visione di un film solo se collegata a una spesa esorbitante al bar, ancor meglio se corredata dai pacchetti film+cena che fanno piacere ai ristoratori del centro commerciale, o alle concessionarie pubblicitarie che confezionano spot dozzinali per il pubblico.
Al contrario, l’esercente old style non ha bisogno di farti sborsare cifre esorbitanti, tanto ha liquidità dagli abbonamenti; non vive sulla vendita di secchioloni unti con popcorn salati, i più integralisti li hanno direttamente banditi; fa a meno della pubblicità commerciale, che tanto manco converte; non ha grandi costi di gestione ed è sostenibile da diversi punti di vista. La rivoluzione è lenta, nel frattempo altre sale chiuderanno, ma la strada è segnata. Chi è impaziente di aprire il solito fast food in franchising può aspettare: il cinema è giovane e bello.